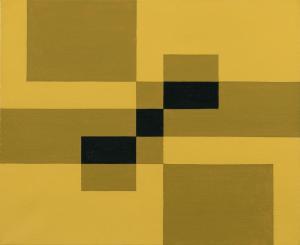U Santétu de Cabanéte restaurato
Tutto cominciò a maggio del 2014, un'iniziativa partita dal basso, all'osteria: Oscar Rossi si fece portavoce e sostenitore della causa. Sembrava cosa da poco, bastavano dei volontari, del materiale e mettersi all'opera. Le cose, però, non si rivelarono così semplici, per cui l'Associazione culturale A Cria di Vallebona prese in carico il "problema" e affrontò le trafile necessarie per arrivare al dunque, come raccontai, a suo tempo qui.
Prima del restauro
Di edicole votive, in dialetto Santéti, a Vallebona, come in tutti gli altri paesi, ce ne sono parecchie. Alcune sono in buono stato, altre sono state mantenute e riparate da privati, una è stata demolita per far passare una strada (e non dico chi ne è responsabile), un'altra è crollata. Insomma: siamo in cammino per salvare il salvabile.
(Cliccando sulle foto è possibile ingrandirle)
Il Santétu de Cabanéte però, è il più particolare di tutti: ci siamo domandati da dove poteva provenire questa architettura, abbiamo chiesto alla gente del paese se ne conosceva la storia, abbiamo contattato, tramite i social net work, professori di ogni genere per cercare di definire questo manufatto.
La restauratrice Raffaella Devalle ha iniziato il suo accurato lavoro attenendosi rigorosamente alle regole previste e nei tempi stabiliti ha portato a compimento l'opera. Anche lei era molto incuriosita e un bel giorno mi dice che un signore, che passa spesso da quel punto, le raccomanda di "aggiustare bene u Santétu".
Solo osservando bene, si possono notare certi particolari: in queste foto, ad esempio, si vede quanto è sconnessa la base che regge la lastra di ardesia su cui poggia il tutto, lastra che col tempo è pure "scivolata" perdendo la sua posizione centrale e simmetrica.
Raffaella procedeva con solerzia: Flavio Guglielmi ha provveduto il materiale per il basamento su cui appoggiare il suo piccolo ponteggio; l'architetto Tullio Gugole ha seguito giorno per giorno i lavori e anch'io facevo i miei sopralluoghi per vedere il work in progress. E quel signore, ogni volta che passava, aggiungeva qualche informazione...
Un giorno le ha portato due vecchi coppi, dicendo a Raffaella che, a suo tempo, erano posti sul retro del Santétu. Purtroppo, non avendo fotografie che possano testimoniare l'affermazione, per regola non si può aggiungere nulla all'esistente e le regole vanno rispettate. Capisco, dalla descrizione di Raffaella, che il "signore" in questione è Luciano Guglielmi e, benché a volte passano mesi senza che io lo veda, dopo mezz'ora il caso ha voluto che lo incontrassi.

Luciano de Vergì sa qualcosa del Santétu, è l'unico che sa dirci qualcosa. Un suo prozio, fratello di Lisà, sua nonna materna (Lisà era esattamente uguale alla nonna delle favole!), morto cinquantenne nel 1927, era un personaggio estroso, insomma, un artista. Costruì lui quel manufatto, nei primi decenni del Novecento. Si chiamava Avustì, al secolo Viale Agostino e faceva delle sculture in legno di noce che ancor oggi Luciano si chiede come abbia potuto realizzarle. Esiste poi un libretto che spiega il significato delle opere scultoree e la mia speranza è che, su quel libretto, ci possa essere anche qualche riga sul significato del Santétu.

Luciano, classe 1940, ricorda di averci sempre visto la statua di Sant'Antonio da Padova ed infatti la proprietaria dell'abitazione adiacente, Viale Graziella, l'aveva tolta e conservata quando si era resa conto della fatiscenza del Santétu, nonostante i numerosi tentativi di intervento che alcuni, nel tempo, avrebbero voluto apportare, ma non fu loro permesso se non interpellando con i permessi le Belle Arti, cosa che per loro si rivelò complicata.
In effetti quella zona apparteneva (ed in parte appartiene ancora) alla famiglia Viale, ovvero i miei antenati. Che il manufatto non richiami esattamente elementi cristiani, non mi stupisce. Esistono documenti che attestano un processo per direttissima, inflitto loro dalla Chiesa, ad alcuni miei avi perché "sorpresi a consegnare dell'olio a San Biagio della Cima in giorno di festa"., sorpresi dunque "a lavorare". L'accusa fu di "eresia" e chissà che non ci sia qualche legame con quel manufatto un po' massonico e arabeggiante, insomma, una sorte di "protesta". Chissà. E chissà se Luciano troverà altre preziose informazioni...
Intanto son ben contenta che sia restaurato e che ospiti proprio Sant'Antonio da Padova: destino vuole che io sia nata proprio il giorno della sua festa!